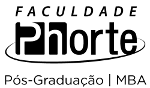907 resultados para Kant, ImmanuelImmanuelKant
Resumo:
Pós-graduação em Psicologia - FCLAS
Resumo:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Resumo:
Pós-graduação em Serviço Social - FCHS
Resumo:
Pós-graduação em Educação - FCT
Resumo:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
Resumo:
We provide conservative translations from propositional modal logic KT (the simplest normal alethic logic) into propositional modal logic KD (the simplest normal deontic logic), and from this into the propositional modal logic K (the simplest normal logic simpliciter). Following an idea discussed by Jaakko Hintikka, these conservative translations are based on the third formulation of Kantian categorical imperative, the formulation of the Kingdom of Ends.
Resumo:
Based on the study of some philosophical schools – such as the Cartesian Racionalism, the Empiricism of Hume and Kant’s Criticism – and of some brief remarks on Mathematics in ancient world – particularly the greek Mathematics – this paper intends to understand how the euclidean ideas have been taken for a long time as a model of how to geometrize and of what Mathematics is.
Resumo:
Background Floating-Harbor syndrome (FHS) is a rare condition characterized by short stature, delays in expressive language, and a distinctive facial appearance. Recently, heterozygous truncating mutations in SRCAP were determined to be disease-causing. With the availability of a DNA based confirmatory test, we set forth to define the clinical features of this syndrome. Methods and results Clinical information on fifty-two individuals with SRCAP mutations was collected using standardized questionnaires. Twenty-four males and twenty-eight females were studied with ages ranging from 2 to 52 years. The facial phenotype and expressive language impairments were defining features within the group. Height measurements were typically between minus two and minus four standard deviations, with occipitofrontal circumferences usually within the average range. Thirty-three of the subjects (63%) had at least one major anomaly requiring medical intervention. We did not observe any specific phenotype-genotype correlations. Conclusions This large cohort of individuals with molecularly confirmed FHS has allowed us to better delineate the clinical features of this rare but classic genetic syndrome, thereby facilitating the development of management protocols.
Resumo:
Em conformidade com a dúvida de seu título, o difundido livro The New Brutalism: Ethic or Aesthetic? de Reyner Banham não é possível explicar o Brutalismo como manifestação artística coesa, dotada de consistência e reprodutibilidade formal. A citação de arquitetos famosos, porém divergentes, parece associar e comparar obras ásperas com a pretensão de reerguer uma arquitetura moderna considerada ascética, monótona e insuficiente e gera um teoricismo da aparência crua e do moralismo dos objetos. Discurso que oculta, ou desvia a atenção do retorno artístico à sublimidade e construção artesanal. O Brutalismo é aceito como evolução natural dos estágios modernos anteriores e sanciona artefatos toscos, pesados e inacabados como se fossem filiados ao processo moderno desinfestado. Esconde contradições e disfarça seu rompimento com o moderno para prolongar a expressão Movimento moderno. Mas o objeto claro, econômico e preciso é repudiado pelo consumidor e, por ser pouco representativo, o artista faz sua maquiagem com episódios contrastantes e monumentais na informalidade das cidades espontâneas. No entanto, parece possível suspender a noção positiva e corretiva do Brutalismo para entendê-lo como um recuo artístico vulgarizador que despreza aperfeiçoamento e afronta a atitude moderna com banalização conceptiva, exagero, figuralidade, musculação estrutural, grandeza tectônica, rudimento e rudeza. Assim, moralismo, retorno rústico e originalidade desqualificam a expressão International Style entendida como a culminação da arquitetura moderna do pós-guerra, ao depreciá-la como decadente, como produto imobiliário, comercial e corporativo a serviço do capital. Essa interpretação desvela uma crítica anti-industrial, portanto antimodernista e diversa da pós-modernidade, porém contestadora e realista para fornecer imagens à cultura e aos insensíveis à estrutura da forma moderna. Diverso da pós-modernidade pela dependência ao moderno e ausência de apelo popular. Tornada insignificante a configuração oportuna do artefato, o arquiteto tenta reter sua notabilidade artística, ou o prestígio que parece enfraquecer na aparência símile da especificação de catálogo, no rigor modular. Indispõe-se e repudia componentes, Standards e acabamentos impessoais da indústria da construção para insistir em autoria e inspiração, mas repete cacoetes estilísticos de época e o inexplicável uso intensivo de concreto bruto e aparente para sentir-se engajado e atualizado. Porém, é necessário distinguir obras de aparência severa concebidas pela atitude moderna mais autêntica das de concreto aparente em tipos ou configurações aberrantes. Para avançar na discussão do Brutalismo propõe-se entender este fenômeno com a substituição do juízo estético moderno de sentido visual postulado por Immanuel Kant (1724-1804) por um sentimento estético fácil e relacionado com a sensação da empatia, com a Einfühlung de Robert Vischer (1847-1933). Na época da cultura de massas, admite-se o rebaixamento das exigências no artefato e a adaptação brutalista com a transfiguração dos processos de arquitetura moderna. Assim, a forma é substituída pela figura ou pelo resumo material; a estrutura formal subjacente pelo ritmo e exposição da estrutura física; o reconhecimento visual pelo entusiasmo psicológico ou pelo impulso dionisíaco; a concepção substituída pelo partido, ou, ainda, pelo conceito; a sistematização e a ordem pela moldagem e a organização; a abstração e síntese pela originalidade e essencialidade, o sentido construtivo pela honestidade material; a identidade das partes pela fundição ou pela unicidade objetal e a residência pela cabana primitiva.
Resumo:
L’ermeneutica filosofica di Hans-Georg Gadamer – indubbiamente uno dei capisaldi del pensiero novecentesco – rappresenta una filosofia molto composita, sfaccettata e articolata, per così dire formata da una molteplicità di dimensioni diverse che si intrecciano l’una con l’altra. Ciò risulta evidente già da un semplice sguardo alla composizione interna della sua opera principale, Wahrheit und Methode (1960), nella quale si presenta una teoria del comprendere che prende in esame tre differenti dimensioni dell’esperienza umana – arte, storia e linguaggio – ovviamente concepite come fondamentalmente correlate tra loro. Ma questo quadro d’insieme si complica notevolmente non appena si prendano in esame perlomeno alcuni dei numerosi contributi che Gadamer ha scritto e pubblicato prima e dopo il suo opus magnum: contributi che testimoniano l’importante presenza nel suo pensiero di altre tematiche. Di tale complessità, però, non sempre gli interpreti di Gadamer hanno tenuto pienamente conto, visto che una gran parte dei contributi esegetici sul suo pensiero risultano essenzialmente incentrati sul capolavoro del 1960 (ed in particolare sui problemi della legittimazione delle Geisteswissenschaften), dedicando invece minore attenzione agli altri percorsi che egli ha seguito e, in particolare, alla dimensione propriamente etica e politica della sua filosofia ermeneutica. Inoltre, mi sembra che non sempre si sia prestata la giusta attenzione alla fondamentale unitarietà – da non confondere con una presunta “sistematicità”, da Gadamer esplicitamente respinta – che a dispetto dell’indubbia molteplicità ed eterogeneità del pensiero gadameriano comunque vige al suo interno. La mia tesi, dunque, è che estetica e scienze umane, filosofia del linguaggio e filosofia morale, dialogo con i Greci e confronto critico col pensiero moderno, considerazioni su problematiche antropologiche e riflessioni sulla nostra attualità sociopolitica e tecnoscientifica, rappresentino le diverse dimensioni di un solo pensiero, le quali in qualche modo vengono a convergere verso un unico centro. Un centro “unificante” che, a mio avviso, va individuato in quello che potremmo chiamare il disagio della modernità. In altre parole, mi sembra cioè che tutta la riflessione filosofica di Gadamer, in fondo, scaturisca dalla presa d’atto di una situazione di crisi o disagio nella quale si troverebbero oggi il nostro mondo e la nostra civiltà. Una crisi che, data la sua profondità e complessità, si è per così dire “ramificata” in molteplici direzioni, andando ad investire svariati ambiti dell’esistenza umana. Ambiti che pertanto vengono analizzati e indagati da Gadamer con occhio critico, cercando di far emergere i principali nodi problematici e, alla luce di ciò, di avanzare proposte alternative, rimedi, “correttivi” e possibili soluzioni. A partire da una tale comprensione di fondo, la mia ricerca si articola allora in tre grandi sezioni dedicate rispettivamente alla pars destruens dell’ermeneutica gadameriana (prima e seconda sezione) ed alla sua pars costruens (terza sezione). Nella prima sezione – intitolata Una fenomenologia della modernità: i molteplici sintomi della crisi – dopo aver evidenziato come buona parte della filosofia del Novecento sia stata dominata dall’idea di una crisi in cui verserebbe attualmente la civiltà occidentale, e come anche l’ermeneutica di Gadamer possa essere fatta rientrare in questo discorso filosofico di fondo, cerco di illustrare uno per volta quelli che, agli occhi del filosofo di Verità e metodo, rappresentano i principali sintomi della crisi attuale. Tali sintomi includono: le patologie socioeconomiche del nostro mondo “amministrato” e burocratizzato; l’indiscriminata espansione planetaria dello stile di vita occidentale a danno di altre culture; la crisi dei valori e delle certezze, con la concomitante diffusione di relativismo, scetticismo e nichilismo; la crescente incapacità a relazionarsi in maniera adeguata e significativa all’arte, alla poesia e alla cultura, sempre più degradate a mero entertainment; infine, le problematiche legate alla diffusione di armi di distruzione di massa, alla concreta possibilità di una catastrofe ecologica ed alle inquietanti prospettive dischiuse da alcune recenti scoperte scientifiche (soprattutto nell’ambito della genetica). Una volta delineato il profilo generale che Gadamer fornisce della nostra epoca, nella seconda sezione – intitolata Una diagnosi del disagio della modernità: il dilagare della razionalità strumentale tecnico-scientifica – cerco di mostrare come alla base di tutti questi fenomeni egli scorga fondamentalmente un’unica radice, coincidente peraltro a suo giudizio con l’origine stessa della modernità. Ossia, la nascita della scienza moderna ed il suo intrinseco legame con la tecnica e con una specifica forma di razionalità che Gadamer – facendo evidentemente riferimento a categorie interpretative elaborate da Max Weber, Martin Heidegger e dalla Scuola di Francoforte – definisce anche «razionalità strumentale» o «pensiero calcolante». A partire da una tale visione di fondo, cerco quindi di fornire un’analisi della concezione gadameriana della tecnoscienza, evidenziando al contempo alcuni aspetti, e cioè: primo, come l’ermeneutica filosofica di Gadamer non vada interpretata come una filosofia unilateralmente antiscientifica, bensì piuttosto come una filosofia antiscientista (il che naturalmente è qualcosa di ben diverso); secondo, come la sua ricostruzione della crisi della modernità non sfoci mai in una critica “totalizzante” della ragione, né in una filosofia della storia pessimistico-negativa incentrata sull’idea di un corso ineluttabile degli eventi guidato da una razionalità “irrazionale” e contaminata dalla brama di potere e di dominio; terzo, infine, come la filosofia di Gadamer – a dispetto delle inveterate interpretazioni che sono solite scorgervi un pensiero tradizionalista, autoritario e radicalmente anti-illuminista – non intenda affatto respingere l’illuminismo scientifico moderno tout court, né rinnegarne le più importanti conquiste, ma più semplicemente “correggerne” alcune tendenze e recuperare una nozione più ampia e comprensiva di ragione, in grado di render conto anche di quegli aspetti dell’esperienza umana che, agli occhi di una razionalità “limitata” come quella scientista, non possono che apparire come meri residui di irrazionalità. Dopo aver così esaminato nelle prime due sezioni quella che possiamo definire la pars destruens della filosofia di Gadamer, nella terza ed ultima sezione – intitolata Una terapia per la crisi della modernità: la riscoperta dell’esperienza e del sapere pratico – passo quindi ad esaminare la sua pars costruens, consistente a mio giudizio in un recupero critico di quello che egli chiama «un altro tipo di sapere». Ossia, in un tentativo di riabilitazione di tutte quelle forme pre- ed extra-scientifiche di sapere e di esperienza che Gadamer considera costitutive della «dimensione ermeneutica» dell’esistenza umana. La mia analisi della concezione gadameriana del Verstehen e dell’Erfahrung – in quanto forme di un «sapere pratico (praktisches Wissen)» differente in linea di principio da quello teorico e tecnico – conduce quindi ad un’interpretazione complessiva dell’ermeneutica filosofica come vera e propria filosofia pratica. Cioè, come uno sforzo di chiarificazione filosofica di quel sapere prescientifico, intersoggettivo e “di senso comune” effettivamente vigente nella sfera della nostra Lebenswelt e della nostra esistenza pratica. Ciò, infine, conduce anche inevitabilmente ad un’accentuazione dei risvolti etico-politici dell’ermeneutica di Gadamer. In particolare, cerco di esaminare la concezione gadameriana dell’etica – tenendo conto dei suoi rapporti con le dottrine morali di Platone, Aristotele, Kant e Hegel – e di delineare alla fine un profilo della sua ermeneutica filosofica come filosofia del dialogo, della solidarietà e della libertà.
Resumo:
La presente ricerca si basa sull’ipotesi che all’interno della tradizione liberale il momento educativo sia tanto importante quanto quello politico. E’ una tesi che non trova molti riscontri nella letteratura intorno al liberalismo, maggiormente propensa a vedere in ogni intervento formativo una minaccia alla libera espressione individuale. L’educazione, secondo questa accezione, conterrebbe una rilevante disposizione ad essere utilizzata ideologicamente, finendo per divenire il più raffinato degli strumenti illiberali. Nel tentativo di contrastare tale ipotesi sono analizzate le principali manifestazioni del liberalismo: contrattualistico (Locke), evoluzionistico (Mandeville, Hume, Smith), giuridico-morale (Kant), liberal-democratico (Tocqueville) e sociale (Dewey). Da tale analisi emerge un particolare modello pedagogico, di natura indiretta e asistematica, che pone al centro della propria riflessione la salvaguardia delle prerogative individuali, senza che questo comporti la sottovalutazione della presenza dell’altro e della creazione di istituzioni sociali giuste. Il processo educativo, inoltre, non può essere visto secondo un’ottica propedeutica nei confronti dell’esperienza politica, contenendo al proprio interno quelle variabili di ordine comportamentale e relazionale in grado di anticipare la stessa vita democratica. Quest’ultima, secondo la celebre definizione di Dewey, non può che essere devota nei confronti dell’educazione, non potendo basarsi esclusivamente su giustificazioni di ordine formale. Il discorso intorno al processo formativo, di conseguenza, allontana il pericolo che il progetto politico liberale si tramuti in mero disegno di stampo “ingegneristico”, senza alcuna considerazione intorno al piano della realizzabilità.
Resumo:
Il presente studio, per ciò che concerne la prima parte della ricerca, si propone di fornire un’analisi che ripercorra il pensiero teorico e la pratica critica di Louis Marin, mettendone in rilievo i caratteri salienti affinché si possa verificare se, nella loro eterogenea interdisciplinarità, non emerga un profilo unitario che consenta di ricomprenderli in un qualche paradigma estetico moderno e/o contemporaneo. Va innanzitutto rilevato che la formazione intellettuale di Marin è avvenuta nell’alveo di quel montante e pervasivo interesse che lo strutturalismo di stampo linguistico seppe suscitare nelle scienze sociali degli anni sessanta. Si è cercato, allora, prima di misurare la distanza che separa l’approccio di Marin ai testi da quello praticato dalla semiotica greimasiana, impostasi in Francia come modello dominante di quella svolta semiotica che ha interessato in quegli anni diverse discipline: dagli studi estetici all’antropologia, dalla psicanalisi alla filosofia. Si è proceduto, quindi, ad un confronto tra l’apparato concettuale elaborato dalla semiotica e alcune celebri analisi del nostro autore – tratte soprattutto da Opacité de la peinture e De la représentation. Seppure Marin non abbia mai articolato sistematicametne i principi teorici che esplicitassero la sua decisa contrapposizione al potente modello greimasiano, tuttavia le reiterate riflessioni intorno ai presupposti epistemologici del proprio modo di interpretare i testi – nonché le analisi di opere pittoriche, narrative e teoriche che ci ha lasciato in centinaia di studi – permettono di definirne una concezione estetica nettamente distinta dalla pratica semio-semantica della scuola di A. J. Greimas. Da questo confronto risulterà, piuttosto, che è il pensiero di un linguista sui generis come E. Benveniste ad avere fecondato le riflessioni di Marin il quale, d’altra parte, ha saputo rielaborare originalmente i contributi fondamentali che Benveniste diede alla costruzione della teoria dell’enunciazione linguistica. Impostando l’equazione: enunciazione linguistica=rappresentazione visiva (in senso lato), Marin diviene l’inventore del dispositivo concettuale e operativo che consentirà di analizzare l’enunciazione visiva: la superficie di rappresentazione, la cornice, lo sguardo, l’iscrizione, il gesto, lo specchio, lo schema prospettico, il trompe-l’oeil, sono solo alcune delle figure in cui Marin vede tradotto – ma in realtà immagina ex novo – quei dispositivi enunciazionali che il linguista aveva individuato alla base della parole come messa in funzione della langue. Marin ha saputo così interpretare, in modo convincente, le opere e i testi della cultura francese del XVII secolo alla quale sono dedicati buona parte dei suoi studi: dai pittori del classicismo (Poussin, Le Brun, de Champaigne, ecc.) agli eruditi della cerchia di Luigi XIV, dai filosofi (soprattutto Pascal), grammatici e logici di Port-Royal alle favole di La Fontaine e Perrault. Ma, come si evince soprattutto da testi come Opacité de la peinture, Marin risulterà anche un grande interprete del rinascimento italiano. In secondo luogo si è cercato di interpretare Le portrait du Roi, il testo forse più celebre dell’autore, sulla scorta dell’ontologia dell’immagine che Gadamer elabora nel suo Verità e metodo, non certo per praticare una riduzione acritica di due concezioni che partono da presupposti divergenti – lo strutturalismo e la critica d’arte da una parte, l’ermeneutica filosofica dall’altra – ma per rilevare che entrambi ricorrono al concetto di rappresentazione intendendolo non tanto come mimesis ma soprattutto, per usare il termine di Gadamer, come repraesentatio. Sia Gadamer che Marin concepiscono la rappresentazione non solo come sostituzione mimetica del rappresentato – cioè nella direzione univoca che dal rappresentato conduce all’immagine – ma anche come originaria duplicazione di esso, la quale conferisce al rappresentato la sua legittimazione, la sua ragione o il suo incremento d’essere. Nella rappresentazione in quanto capace di legittimare il rappresentato – di cui pure è la raffigurazione – abbiamo così rintracciato la cifra comune tra l’estetica di Marin e l’ontologia dell’immagine di Gadamer. Infine, ci è sembrato di poter ricondurre la teoria della rappresentazione di Marin all’interno del paradigma estetico elaborato da Kant nella sua terza Critica. Sebbene manchino in Marin espliciti riferimenti in tal senso, la sua teoria della rappresentazione – in quanto dire che mostra se stesso nel momento in cui dice qualcos’altro – può essere intesa come una riflessione estetica che trova nel sensibile la sua condizione trascendentale di significazione. In particolare, le riflessioni kantiane sul sentimento di sublime – a cui abbiamo dedicato una lunga disamina – ci sono sembrate chiarificatrici della dinamica a cui è sottoposta la relazione tra rappresentazione e rappresentato nella concezione di Marin. L’assolutamente grande e potente come tratti distintivi del sublime discusso da Kant, sono stati da noi considerati solo nella misura in cui ci permettevano di fare emergere la rappresentazione della grandezza e del potere assoluto del monarca (Luigi XIV) come potere conferitogli da una rappresentazione estetico-politica costruita ad arte. Ma sono piuttosto le facoltà in gioco nella nostra più comune esperienza delle grandezze, e che il sublime matematico mette esemplarmente in mostra – la valutazione estetica e l’immaginazione – ad averci fornito la chiave interpretativa per comprendere ciò che Marin ripete in più luoghi citando Pascal: una città, da lontano, è una città ma appena mi avvicino sono case, alberi, erba, insetti, ecc… Così abbiamo applicato i concetti emersi nella discussione sul sublime al rapporto tra la rappresentazione e il visibile rappresentato: rapporto che non smette, per Marin, di riconfigurarsi sempre di nuovo. Nella seconda parte della tesi, quella dedicata all’opera di Bernard Stiegler, il problema della comprensione delle immagini è stato affrontato solo dopo aver posto e discusso la tesi che la tecnica, lungi dall’essere un portato accidentale e sussidiario dell’uomo – solitamente supposto anche da chi ne riconosce la pervasività e ne coglie il cogente condizionamento – deve invece essere compresa proprio come la condizione costitutiva della sua stessa umanità. Tesi che, forse, poteva essere tematizzata in tutta la sua portata solo da un pensatore testimone delle invenzioni tecnico-tecnologiche del nostro tempo e del conseguente e radicale disorientamento a cui esse ci costringono. Per chiarire la propria concezione della tecnica, nel I volume di La technique et le temps – opera alla quale, soprattutto, sarà dedicato il nostro studio – Stiegler decide di riprendere il problema da dove lo aveva lasciato Heidegger con La questione della tecnica: se volgiamo coglierne l’essenza non è più possibile pensarla come un insieme di mezzi prodotti dalla creatività umana secondo un certi fini, cioè strumentalmente, ma come un modo di dis-velamento della verità dell’essere. Posto così il problema, e dopo aver mostrato come i sistemi tecnici tendano ad evolversi in base a tendenze loro proprie che in buona parte prescindono dall’inventività umana (qui il riferimento è ad autori come F. Gille e G. Simondon), Stiegler si impegna a riprendere e discutere i contributi di A. Leroi-Gourhan. È noto come per il paletnologo l’uomo sia cominciato dai piedi, cioè dall’assunzione della posizione eretta, la quale gli avrebbe permesso di liberare le mani prima destinate alla deambulazione e di sviluppare anatomicamente la faccia e la volta cranica quali ondizioni per l’insorgenza di quelle capacità tecniche e linguistiche che lo contraddistinguono. Dei risultati conseguiti da Leroi-Gourhan e consegnati soprattutto in Le geste et la parole, Stiegler accoglie soprattutto l’idea che l’uomo si vada definendo attraverso un processo – ancora in atto – che inizia col primo gesto di esteriorizzazione dell’esperienza umana nell’oggetto tecnico. Col che è già posta, per Stiegler, anche la prima forma di simbolizzazione e di rapporto al tempo che lo caratterizzano ancora oggi. Esteriorità e interiorità dell’uomo sono, per Stiegler, transduttive, cioè si originano ed evolvono insieme. Riprendendo, in seguito, l’anti-antropologia filosofica sviluppata da Heidegger nell’analitica esistenziale di Essere e tempo, Stiegler dimostra che, se si vuole cogliere l’effettività della condizione dell’esistenza umana, è necessaria un’analisi degli oggetti tecnici che però Heidegger relega nella sfera dell’intramondano e dunque esclude dalla temporalità autentica dell’esser-ci. Se è vero che l’uomo – o il chi, come lo chiama Stiegler per distinguerlo dal che-cosa tecnico – trova nell’essere-nel-mondo la sua prima e più fattiva possibilità d’essere, è altrettanto verò che questo mondo ereditato da altri è già strutturato tecnicamente, è già saturo della temporalità depositata nelle protesi tecniche nelle quali l’uomo si esteriorizza, e nelle quali soltanto, quindi, può trovare quelle possibilità im-proprie e condivise (perché tramandate e impersonali) a partire dalle quali poter progettare la propria individuazione nel tempo. Nel percorso di lettura che abbiamo seguito per il II e III volume de La technique et le temps, l’autore è impegnato innanzitutto in una polemica serrata con le analisi fenomenologiche che Husserl sviluppa intorno alla coscienza interna del tempo. Questa fenomenologia del tempo, prendendo ad esame un oggetto temporale – ad esempio una melodia – giunge ad opporre ricordo primario (ritenzione) e ricordo secondario (rimemorazione) sulla base dell’apporto percettivo e immaginativo della coscienza nella costituzione del fenomeno temporale. In questo modo Husserl si preclude la possibilità di cogliere il contributo che l’oggetto tecnico – ad esempio la registrazione analogica di una melodia – dà alla costituzione del flusso temporale. Anzi, Husserl esclude esplicitamente che una qualsiasi coscienza d’immagine – termine al quale Stiegler fa corrispondere quello di ricordo terziario: un testo scritto, una registrazione, un’immagine, un’opera, un qualsiasi supporto memonico trascendente la coscienza – possa rientrare nella dimensione origianaria e costitutiva di tempo. In essa può trovar posto solo la coscienza con i suo vissuti temporali percepiti, ritenuti o ricordati (rimemorati). Dopo un’attenta rilettura del testo husserliano, abbiamo seguito Stiegler passo a passo nel percorso di legittimazione dell’oggetto tecnico quale condizione costitutiva dell’esperienza temporale, mostrando come le tecniche di registrazione analogica di un oggetto temporale modifichino, in tutta evidenza, il flusso ritentivo della coscienza – che Husserl aveva supposto automatico e necessitante – e con ciò regolino, conseguente, la reciproca permeabilità tra ricordo primario e secondario. L’interpretazione tecnica di alcuni oggetti temporali – una foto, la sequenza di un film – e delle possibilità dispiegate da alcuni dispositivi tecnologici – la programmazione e la diffusione audiovisiva in diretta, l’immagine analogico-digitale – concludono questo lavoro richiamando l’attenzione sia sull’evidenza prodotta da tali esperienze – evidenza tutta tecnica e trascendente la coscienza – sia sul sapere tecnico dell’uomo quale condizione – trascendentale e fattuale al tempo stesso – per la comprensione delle immagini e di ogni oggetto temporale in generale. Prendendo dunque le mosse da una riflessione, quella di Marin, che si muove all’interno di una sostanziale antropologia filosofica preoccupata di reperire, nell’uomo, le condizioni di possibilità per la comprensione delle immagini come rappresentazioni – condizione che verrà reperità nella sensibilità o nell’aisthesis dello spettatore – il presente lavoro passerà, dunque, a considerare la riflessione tecno-logica di Stiegler trovando nelle immagini in quanto oggetti tecnici esterni all’uomo – cioè nelle protesi della sua sensibilità – le condizioni di possibilità per la comprensione del suo rapporto al tempo.
Resumo:
Este estudio se propone indagar el problema de la relación entre individuo, multitud y libertad en la obra de Spinoza, problema que, es nuestra hipótesis, permite echar luz sobre las alternativas fundamentales que se pusieron en juego en el debate teórico-político de la primera modernidad, y consecuentemente, en la formación de los órdenes políticos secularizados contemporáneos. ¿Cómo es posible la fundación y la conservación de un orden político en estas condiciones de incertidumbre? Más aún: ¿cómo hacer de esta incertidumbre no ya una amenaza, sino la fuerza motriz de un orden político? Estas son algunas de las preguntas que Spinoza responde a partir de una política y una filosofía de la inmanencia y que presentan, para nosotros, el doble interés de una interrogación “histórica” que busca en los orígenes de la modernidad sus posibilidades no transitadas, y “teórico política” en tanto busca en la ontología política spinoziana una forma de interrogar, desde las posibilidades inscriptas en su origen, las encrucijadas de la política moderna. Para llevar adelante esta investigación tomaremos como punto de partida la noción spinoziana de individualidad, buscando comprender sus determinaciones, su especificidad y el modo en que, a partir de ella, resulta posible pensar la "naturaleza humana" y las condiciones de la vida en común. Esta noción de individualidad, sostendremos, implica una crítica moderna de las categorías centrales del proyecto moderno, cuya clave se encuentra justamente en una crítica radical de la concepción moderna de la subjetividad (ya sea en su dimensión individual, como concepción del hombre, o en su dimensión política, como concepción del sujeto soberano). A partir de este desarrollo, daremos tratamiento a la concepción spinoziana de la política, y del que se revela en sus últimos escritos como su actor fundamental: la multitud. Para ello, hemos pretendido poner de relieve la distancia de Spinoza respecto del paradigma de la soberanía estatal desarrollado por Hobbes (y continuado en toda la tradición filosófica del derecho natural, pasando por Locke, Rousseau y Kant) y las consecuencias históricas, políticas e institucionales de tal distancia, así como las posibilidades abiertas a un pensamiento político a partir del registro conceptual abierto por Spinoza.
Resumo:
Die Großherzog Wilhelm Ernst Ausgabe deutscher Klassiker wurde seit 1904 bis in die Zwanziger Jahre hinein im Insel Verlag in Leipzig publiziert. Die Buchreihe hat nicht nur für den Verlag und die Druckerei Poeschel in der sie gedruckt wurde eine ganze Reihe von Neuerungen nach sich gezogen, auch für den deutschen Buchmarkt hat die Klassikerausgabe einen Meilenstein bedeutet. Sie hat einige Eigenschaften des Taschenbuches vorweggenommen. Sie orientierte sich an der Qualität bibliophiler Buchpublikationen, aber war dennoch preislich erschwinglich. Zeitgenössische Klassikerausgaben erschienen zumeist mit einem Kommentar. Nicht so die Großherzog Wilhelm Ernst Ausgabe. Der Text wurde zwar von führenden Wissenschaftlern editiert, aber sie war dennoch unkommentiert. Der Text war in einer Jenson-Antiqua gesetzt obwohl die Debatte um individuell gestaltete Künstlerschriften und die Diskussion um die als deutsche Schrift begriffene Fraktur unter den wichtigsten Protagonisten des deutschen Buchgewerbes ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hatte. Ziel für die Klassikerausgabe war darüber hinaus, das zur Jahrhundertwende leicht angestaubte Image der Stadt Weimar aufzupolieren. Über das Patronat des Großherzogs hinaus hätte man die Gewinne aus dem Verkauf der Bücher der Permanenten Ausstellung für die Anschaffung von modernen Kunstobjekten zur Verfügung stellen wollen, die unter der Leitung von Harry Graf Kessler stand. Sieht man den Inhalt der Werke der in der Klassikerreihe erschienen Dichter Goethe, Schiller und Körner in einem ästhetischen Kontext mit dem der Philosophen Schopenhauer und Kant, wird im Spiegel der Formalästhetik der Klassikerausgabe Graf Kesslers Bildungs- und Kulturbegriff erkennbar, der sich in den Jahren nach der Jahrhundertwende zu seinem Lebenskunstideal verdichtete. Der zerrütteten Existenz der Zeitgenossen, wie Friedrich Nietzsche sie beschrieben hatte, sollte der Inhalt der Ausgabe in seiner modernen Form eine moderne Wertehaltung entgegensetzen. Die Lektüre der Klassiker sollte den deutschen Philister „entkrampfen“ und ihm ein Stück der verloren geglaubten Lebensfreude wieder zurück bringen, in dem dieser auch die Facetten des Lebensleids als normal hinnehmen und akzeptieren lernte. Die Klassikerausgabe repräsentierte aus diesem Grund auch den kulturellen und politischen Reformwillen und die gesellschaftlichen Vorstellungen die der Graf für ein modernes Deutschland als überfällig erachtete. Die Buchreihe war aus diesem Grund auch ein politisches Statement gegen die Beharrungskräfte im deutschen Kaiserreich. Die Klassikerreihe wurde in der buchhistorischen Forschung zwar als bedeutender Meilenstein charakterisiert und als „wichtiges“ oder gar „revolutionäres“ Werk der Zeit hervorgehoben, die Ergebnisse der Forschung kann man überspitzt aber in der Aussage zusammenfassen, dass es sich bei der Großherzog Wilhelm Ernst Ausgabe um einen „zufälligen Glückstreffer“ deutscher Buchgestaltung zu handeln scheint. Zumindest lassen die Aussagen, die bisher in dieser Hinsicht gemacht wurden, keine eindeutige Einordnung zu, außer vielleicht der, dass die Klassiker von der englischen Lebensreform inspiriert wurden und Henry van de Velde und William Morris einen Einfluss auf ihre äußere Form hatten. Gerade die Gedankenansätze dieser Beiden nutzte Graf Kessler aber für eigene Überlegungen, die ihn schließlich auch zu eigenen Vorstellungen von idealer Buchgestaltung brachten. Da für Kessler auch Gebrauchsgegenstände Kunst sein konnten, wird das Konzept der Klassikerausgabe bis zur Umsetzung in ihrer `bahnbrechenden´ Form in das ideengeschichtliche und ästhetische Denken des Grafen eingeordnet. Die Klassiker werden zwar in buchhistorischen Einzeluntersuchungen bezüglich ihrer Komponenten, dem Dünndruckpapier, ihrem Einband oder der Schrifttype exponiert. In buchwissenschaftlichen Überblicksdarstellungen wird ihr Einfluss hingegen weniger beachtet, denn verschiedene Kritiker bezogen sie seit ihrem ersten Erscheinen nicht als deutsches Kulturgut mit ein, denn sie lehnten sowohl die englischen Mitarbeiter Emery Walker, Edward Johnston, Eric Gill und Douglas Cockerell wie auch ihre Gestaltung als „welsche“ Buchausgabe ab. Richtig ist, die Großherzog Wilhelm Ernst Ausgabe hatte dieselbe Funktion wie die von Graf Kessler in Weimar konzipierten Kunstausstellungen und die dortige Kunstschule unter der Leitung seines Freundes Henry van de Velde. Auch das für Weimar geplante Theater, das unter der Leitung von Hugo von Hofmannsthal hätte stehen sollen und die Großherzog Wilhelm Ernst Schule, hätten dieselben Ideen der Moderne mit anderen Mitteln transportieren sollen, wie die Großherzog Wilhelm Ernst Ausgabe deutscher Klassiker.